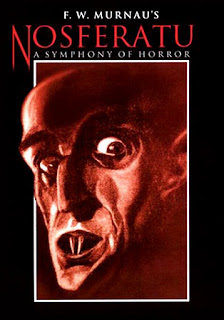La vita di Gesù Cristo fedelmente raccontata in base al Vangelo dell’apostolo Matteo. Come nel testo ispiratore la storia è divisa in 4 parti principali:
- Annunciazione, nascita e fuga in Egitto
- Le predicazioni in Galilea
- Arrivo nella città santa di Gerusalemme
- Il processo, la Passione, la morte e la Resurrezione
Ci sono registi dei quali è impossibile parlare, per cercare di capirne le opere, senza conoscerne la vicenda umana. Probabilmente Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5/3/1922 – Roma, 2/11/1975) è quello a cui meglio si addice questa affermazione. Artista versatile, dallo sguardo sempre critico ed attento, nonché uomo di profondissima cultura, sensibilità ed impegno politico e civile, Pasolini è giustamente considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del secolo scorso. Una figura di spicco della nostra cultura, che ha sempre guardato molto lontano con le sue opere e la sua estetica, al punto che, ancora oggi, a più di 30 anni dalla sua tragica e misteriosa morte, non tutto è stato completamente compreso e recepito del Pasolini pensiero. Personaggio scomodo e controverso, che ha sempre diviso la critica per il suo essere, al tempo stesso, ardito, radicale, libero e poetico a livelli sublimi. Tantissimi gli aggettivi che si potrebbero utilizzare per descrivere il Pasolini uomo ed artista: scrittore, poeta, filosofo, marxista, geniale, ateo, regista, attore, omosessuale, e si potrebbe continuare a lungo. Uno degli aspetti che mi ha sempre colpito della vita di Pasolini è che, spesso, il suo pensiero ed il suo “essere contro” fu oggetto di critiche e di polemiche accese sia da parte della destra borghese reazionaria che della sinistra estrema (la sua ideale corrente politica) o moderata: si pensi, ad esempio, alle sue spiazzanti dichiarazioni in merito agli scontri di Valle Giulia, avvenuti a Roma il 1 marzo 1968.
Lungi da me voler mettere a fuoco Pasolini in queste poche righe, credo però che sia importante conoscere, almeno sommariamente, alcuni aspetti della sua personalità, per meglio capirne le opere, in questo caso lo splendido capolavoro che è “Il Vangelo secondo Matteo”. Secondo lo scrivente esso è, di gran lunga, il miglior film di Pasolini ed il miglior film mai girato sulla vita e le opere di Cristo, quello in cui il regista bolognese riesce a bilanciare meglio che in qualunque altro i suoi stilemi quali: capacità lirica, visionarietà poetica, rigore laico, arguta riflessione sociologica e politica, oltre che il suo innato approccio viscerale all’arte ed alla vita.
Pasolini “scoprì” il Vangelo per la prima volta nel 1942 e lo rilesse poi più approfonditamente nel 1962 ad Assisi, in occasione di una sua visita nella città umbra durante la quale voleva incontrare Papa Giovanni XXIII, da lui molto stimato. Nonostante il suo essere marxista e non credente, Pasolini rimase molto affascinato, per sua stessa esplicita ammissione, dai testi sacri e, in particolare, dalla carismatica e rivoluzionaria figura di Gesù Cristo. In molte interviste egli parla con enorme ammirazione e dolcezza della “bellezza morale”, della “rivoluzionaria forza interiore” del Cristo e di come la sua eroica parabola terrena diventi un’altissima metafora del concetto stesso di divinità in modo purissimo, bene al di là di ogni possibile (e limitante) credo teologico. Pasolini era assolutamente rapito ed ammaliato dalla figura di Cristo, dall’enorme portata etica della sua opera, della sua vita e della sua morte e decise, contro tutto e tutti, di fare un film sul Vangelo. Bisogna infatti ricordare che la Chiesa aveva spesso bandito e censurato il regista poeta, accusandolo di blasfemia ed offesa alla religione di stato, specialmente a causa del controverso e visionario episodio “La ricotta”, inserito nel film “Ro.Go.Pa.G.” (1963). “La ricotta” è una coraggiosa e surreale parodia della Passione di Cristo, in cui Pasolini mescola abilmente sacro e profano, politica e religione, utilizzando in modo ardito la sua poetica degli umili e le sue ambientazioni da neorealismo di borgata per “rivisitare”, con un film nel film, le ultime ore della vita di Gesù. Utilizza addirittura come protagonista il mito Orson Welles, che fa la parte del regista e che esprime (doppiato, ahinoi) il Pasolini pensiero sulla politica e sulla società del tempo. Assolutamente memorabile, al riguardo, la sua definizione di Federico Fellini, detta per bocca di Welles (“egli danza…”). Nonostante alcune sequenze geniali e visionarie, stilisticamente pregevoli e visivamente elegantissime (le due deposizioni del Cristo crocifisso che ricalcano pedissequamente i dipinti di Rosso Fiorentino e del Pontorno), nonostante le moltissime citazioni finissime e coltissime, gli ossimori utilizzati erano (o sono?) davvero troppo per il moralismo bigotto di quei tempi. Il Cristo volgare e ruspante de “La ricotta” (Stracci), insieme ad alcuni concetti espressi per bocca del divo Welles, suscitarono le ire e gli strali della Chiesa e molte furono le persecuzioni censorie verso il film e verso Pasolini, che, alla fine, si vide costretto a modificarne alcune parti. E’ facile dunque capire quali e quante perplessità furono suscitate dalla decisione del regista di realizzare un film sul Vangelo, appena un anno dopo il terremoto ideologico provocato da “La ricotta”.
Eppure, il “miracolo” riesce: Pasolini sceglie scientemente il più “laico” dei quattro Vangeli, quello di Matteo, dove meglio traspare il lato umano del Cristo, il suo essere persino, a volte, severo e combattivo, altre volte cupo, sconsolato e quasi avvinto dall’enorme peso del suo destino. Il Vangelo di Matteo presenta, maggiormente rispetto agli altri, una struttura ad episodi (quattro) quasi a se stanti, con balzi temporali ed ellissi nella narrazione e Pasolini si rifà ad esso rigorosamente, fedelmente ed in modo pressoché assoluto. Invero, alcune piccole differenze sono riscontrabili soprattutto nella dilatazione di alcuni episodi da parte del regista, in particolare per mettere in risalto (con estrema efficacia e sublime poesia) il dramma umano ed interiore di alcuni personaggi quali Maria, Pietro o Giuda. Ma questi “peccati veniali”, commessi in nome del lirismo pasoliniano, nulla tolgono alla fedeltà testo-film, anzi migliorano il senso artistico dell’opera, regalandoci momenti intensi, struggenti e sublimi. In particolare la sequenza del tradimento di Simon Pietro è un momento di grandissimo cinema e di superba regia, con quello zoom in - zoom out eseguito con la camera a mano, a sottolineare i diversi stati d’animo di paura, vergogna e dolore. Il “miracolo” riesce, dicevamo, e così un marxista, un non credente, boicottato dalla Chiesa e dalla morale borghese riesce nell’impresa di raccontare, con sguardo laico e stile asciutto, la storia di Gesù Cristo, raggiungendo vette di altissima poesia e di sublime misticismo come mai più nella sua carriera, pur non rinunciando ai contenuti a sfondo politico e sociale, qui però elevati su una dimensione ascetica ed universale. In tal senso, questo “miracolo” è figlio dei suoi tempi: tempi in cui si avvia il dialogo e la distensione tra la sinistra e la religione cattolica, anche grazie ad insigni figure come papa Giovanni XXIII o Aldo Moro. Dialogo che, più in avanti, culminerà con il “compromesso storico” ed il primo governo a partecipazione di sinistra. E, non a caso, il film di Pasolini è dedicato al “papa buono”. Ecco, come premesso in avvio, che vita ed arte, contesto storico-sociale ed opera cinematografica, per Pasolini più che per chiunque altro, si intersecano, si influenzano e si confondono in una sinergia di intenti e di ambizioni. Dopo avere effettuato alcuni sopralluoghi in Palestina (nei veri luoghi della vita del Cristo), Pasolini si convince (anche per motivi di budget) di girare il film a Matera, nel Meridione d’Italia, e ricorre, coerentemente alla sua estetica, ad attori non professionisti, sconosciuti e comparse prese in loco (contadini dal volto fiero e segnato da una vita rude e faticosa). La splendida fotografia in bianco e nero di Tonino Delli Colli e le superbe musiche di Luis Bacalov (mescolate a classici come Bach e Mozart) si aggiungono a magnificare il tutto, dando vita ad un capolavoro di rara bellezza. Per la cruciale scelta del personaggio principale, il regista si affidò, coraggiosamente, ad un giovane studente spagnolo (Enrique Irazoqui), conosciuto quasi per caso perché questi stava scrivendo una tesi sulle poesie di Pier Paolo Pasolini. I tratti somatici spigolosi e poco “cristologici” del giovane catalano (tra l’altro doppiato dall’ottimo Enrico Maria Salerno) ci regalano un Cristo atipico già nell’aspetto, un Cristo pensoso e scuro in volto, raramente angelico, più medievale che prossimo alla tranquillizzante iconografia rinascimentale, alla quale siamo più abituati. Lo stile registico è rigoroso, c’è un notevole utilizzo della camera a mano (regalando al tutto un estremo realismo), vi sono frequenti passaggi dai campi lunghi ai primi piani, rimarcando così sia lo spirito epico che gli stati d’animo dei personaggi, ed anche l’utilizzo del montaggio è spesso geniale e visionario (specialmente nel meraviglioso “Discorso della Montagna” dove si alternano le zoomate sul volto di Cristo, le parabole e le immagini simboliche). Il contrasto tra il Pasolini laico e non credente ed il Pasolini “innamorato” di Cristo, è il motivo trainante su cui si basa la pellicola e da cui nascono la sua carica emotiva e la sua incredibile tensione spirituale. E quando queste due forze antitetiche raggiungono un equilibrio si hanno i momenti più elevati, profondi e poetici del cinema di Pasolini. La forza del Cristo di Pasolini è nella parola più che nelle azioni, parole a volte sussurrate a volte urlate con forza, a sottolineare la sua carica umana ed il suo carisma. Una cosa che colpisce molto nel film è la posizione morale di Pasolini rispetto alla storia che sta raccontando, posizione che poi si traduce nella bellissima estetica che vediamo sullo schermo. Egli si accosta al Cristo, nonostante il suo ateismo, con profondo rispetto, con un candore ed una “pudicizia” etica ed intellettuale che non può non sbalordire. Questo è evidente non solo nelle scene di più profonda empatia e partecipazione emotiva (il Discorso della Montagna, il Getsemani, la Deposizione) ma soprattutto nelle scene in cui il regista sceglie di restare in disparte: si pensi al modo di riprendere il processo (dal punto di vista di Simon Pietro) o la Via Crucis (con camera a mano e dal punto di vista della folla). Questo distacco nasce da un senso di profondissimo rispetto che oserei definire pudico: Pasolini sceglie di non essere né di fronte né di fianco a Cristo nei momenti più terribili della sua vita terrena, ma resta distante (fedele anche al suo concetto di cinema verità con uno stile quasi documentaristico), resta tra le gente, uomo tra gli uomini, evidenziando, altresì, l’impossibilità umana di capire e compenetrare più di tanto il divino e lo spirituale. L’amore è la miglior forma di compenetrazione possibile e Pasolini dimostra di amare la figura del Cristo, di un amore fatto di dolcissimo candore. Egli stesso dichiarò in un’intervista: “Forse è perché sono così poco cattolico che ho potuto amare tanto il vangelo e farne un film”. Un altro aspetto da evidenziare è l’atmosfera: la fusione tra i toni ruvidi della fotografia, le musiche (autentiche protagoniste di moltissime scene) e le immagini (spesso fortemente ispirate, come già avvenuto ne “La ricotta” ad opere pittoriche) ci regala un mondo selvaggio, seminale, quasi preistorico, ma pregno di senso epico e mistico. L’utilizzo delle musiche avviene in modo estremamente eterogeneo ed a volte quasi “ardito”: infatti, in alcune sequenze, la musica sembra in distonia rispetto alle immagini, sempre in accordo all’utilizzo coltissimo degli ossimori o per aumentare la carica espressiva della scena. “Il Vangelo secondo Matteo” è il settimo film di Pasolini e non è solamente il suo film più bello, ma anche il più importante, perché segna il passaggio dal “cinema di borgata” al “cinema di poesia”. Da segnalare, altresì, l’esplicita comparsa del “senso della morte”, che accompagna un po’ tutta la produzione artistica pasoliniana e che troverà il suo estremo e nefasto compimento nel suo ultimo film: “Salò o le 120 giornate di Sodoma”. La pellicola fu giudicata in modo diverso e suscitò reazioni contrastanti (come sempre per il cinema di Pasolini): molti critici di sinistra vollero rimarcarne soprattutto l’aspetto umano ed il contenuto “politico” e marxista (Cristo inteso come figura rivoluzionaria che si dà alle folle per poi portarle nella storia). Molti benpensanti e molti critici di destra criticarono invece il film, sicuramente con un atteggiamento di prevenzione nei confronti dell’autore ma non mancarono critiche anche da certe parti della sinistra. La Chiesa dimostrò invece il suo apprezzamento, addirittura premiando il film. Tutti però riconobbero l’estrema fedeltà al testo evangelico di Matteo. Mi permetto di consigliare questo capolavoro della nostra cinematografia a quanti non lo avessero ancora visto. E’ un film sublime, lontanissimo dagli stereotipi edulcorati di altri kolossal dedicati a Gesù Cristo ed è l’espressione più alta dell’arte e del talento di uno dei maggiori intellettuali vissuti nel nostro paese.